Presentazione di Antonio Pasimeni
LA POESIA POPOLARE RELIGIOSA SALENTINA
1) Caratteristiche generali della poesia e delle leggende sacre (in alcuni paesi si trovano sotto forma poetica, in altri in prosa) del Salento, come quelle di altre regioni italiane, hanno trasposizioni ed accorciamenti di episodi che notoriamente sopravvivono sullo sfondo magico delle superstizioni, dei sogni, delle allegorie e dell’ambiente storico-religioso. Come dovunque, anche qui da noi poggiano sulla base di un sentimento profondo del popolo, magari svisato e sfigurato, o anche inquinato di superstizione, ma sempre impulsivamente sentito. A ragione il Panareo scrive: “Non sarà completa la comprensione dell’anima della gente pugliese senza tener conto così delle credenze, delle tradizioni, delle leggende ed anche dei pregiudizi che formano il suo patrimonio religioso, come di quel complesso di manifestazioni esterne, alle quali il popolo è fortemente attaccato sia che concorrono ad integrare la schietta fede, o che questa ne venga alterata e sopraffatta”. Tutti i materiali possono riuscire preziosi in questo intento, anche quelli come questo, raccolto dall’infaticabile amico Enzo Greco, che raccolto dalla viva voce del popolo e dalla osservazione della vita popolare, a torto sino a qualche tempo fa erano stati trascurati.
A noi preme far notare che ogni poesia, o leggenda che s’incontra nel campo sacro, poggia su un fondamento narrativo, su una leggenda formatasi, cresciuta e deformatasi nel tempo ma che affiora dalla mente del popolo. In quelle del Salento, poi, si nota un sentimento di peculiare valore psicologico come vedremo più avanti. La leggenda va considerata come il nucleo primo della stessa tradizione religiosa, c’è ancora una abbondante vena di fantasia che illegiadrisce il racconto. Si ritrova tutto un mondo in cui religiosità, saggezza, astuzia, amore e passione diventano espressioni dell’anima e della vita spirituale di questo popolo. Alcuni autori come lo Spada o il Rohlfs, parlano di “Animus” ellenico del Salento, di fantasia ellenica fatta insieme di semplicità e di ardore. Sono tutte creazioni che dal pagano si addentrano nel biblico e nel cristiano ma sempre con una ispirazione di tipo magno-greco ove si respira un substrato più o meno evidentemente storico. Nella drammatizzazione dei fatti appare sovrana l’influenza della femminilità entro un velo di bellezza corporale e spirituale, anche questo di stampo ellenico. Questa ricca tradizione iconografica, pone in primo piano il culto dei Santi patroni particolarmente munifici di benefici nei confronti dei devoti, e le poesie popolari costituiscono la manifestazione vivente di gratitudine, di devozione e di una mediazione trascendente sempre presente e viva nella tradizione popolare.
Queste opere tramandate oralmente da gente che il più delle volte non sapeva né leggere, né scrivere, sono molto numerose e costituiscono “documenti” di chiara origine apocrifa che servono a chiosare i testi canonici con ricostruzione dei “punti mancanti”, che aiutano la gente semplice a comprendere i misteri dei Vangeli, a ricordarsene e ad alimentare quella devozione popolare che si è mantenuta intatta nel tempo.
Ed è per questo motivo che nacque una copiosa letteratura apocrifa attorno a tutti quegli episodi che suscitarono emozione per fatti che magari storicamente hanno avuto una nascita diversa ed a volte difficilmente documentabile, ma che avevano fatto sorgere il desiderio di “saperne di più”. Tutti, comunque, offrono una preziosa testimonianza di quanto sia antica la fede popolare, ma sul piano dell’attendibilità storica non si tira fuori nulla.
2) Aspetto psicologico.
Tutto quanto innanzi detto serve a far capire perché di fronte a simili racconti si parla genericamente di “fiabe”; perché queste sono le espressioni più pure e semplici dei processi psichici dell’inconscio collettivo. Nella fiaba, come nella poesia e nei racconti popolari religiosi, si fa uso della magia e dei talismani. Questo ha fatto si che per molti anni è prevalso il pregiudizio che le fiabe, racconti popolari ed altro, non potessero costituire “materiale scientifico”. Solo nel 1800 si manifestò un interesse più spiccatamente storico e scientifico che spinse gli studiosi a tentare di spiegare perché vi fossero in queste storie tanti motivi sempre ricorrenti. Non è il caso qui di addentrarci troppo dettagliatamente negli aspetti interpretativi delle fiabe o delle poesie popolari, si vuole solo mettere in risalto che esistono, tra queste due espressioni di tradizioni, aspetti comuni.
Generalmente Re, Principi e Principesse hanno dato una forma solenne e rituale a tali fatti e, perciò, in un certo senso, più vicino alla coscienza ed al materiale storico conosciuto.
Vi sono molti racconti che presentano o raffigurano modelli della relazione umana tra uomo e donna e che hanno, alla fine, una forma di redenzione reciproca. In questi racconti avviene generalmente che la psiche femminile è descritta più chiaramente di quella maschile.
Facciamo un esempio: la protagonista è bianca (la sposa pura, candida, vittima del maleficio o tradimento), le cognate sono la parte nera (tramano nell’Ombra, contribuiscono ad una ingiustizia). Queste ultime fanno ingelosire il Re e così viene a completarsi una “triade” comune a quasi tutte le fiabe conosciute.
La “Bella sposa bianca” viene spinta nell’acqua ma viene salvata dall’amuleto-(abitino) che la trasporta a riva trasformandosi in una barca (in altre è un’anitra bianca). Ed è qui che l’elemento sacro si fonde con l’evidentissimo elemento magico.
Il Re si avvede dello sbaglio fatto, distrugge la parte nera e riaccoglie la parte bianca.
Questa storia mostra come un fattore che rappresenta la coscienza di una donna possa essere identificato, nello stesso tempo, con l’”Animus” (negativo) di un uomo.
Molti racconti contengono aspetti simili a questo (Re, matrigne, streghe) e descrivono sempre uno svolgimento più o meno identico tanto da farci dedurre che vi è quello che gli studiosi di psicologia chiamano: il Sé.
Antonio Pasimeni
Bibliografia essenziale:
1) - M. Del Donno, Poesia popolare religiosa, Firenze, 1964.
2) - M. L. Von Franz, Le fiabe interpretate, Torino, 1980.
3) - Irene M. Malecore, La poesia popolare nel Salento, Firenze, 1980.
4) - S. Panareo, Canti popolari di Terra d’Otranto, in “Apulia”, I, fasc. IV, II, Fasc. I, II.
5) - L. Spada, L’elemento storico-topografico nelle leggende del Salento, Toritto, 1949.
6) - Il canto popolare salentino, Capone editore, 1992.
7) - G. Gigli, Superstizioni, pregiudizi e tradizioni in Terra d’Otranto, Bologna, 1979.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Scheda n° 37
Titolo: Lu piantu ti Ggesù.
Soggetto: La passione ti Gesù Cristo.
Fonte: Giulia Ciaccioli, anni 80.
Data rilevazione: 1992.
Luogo: Mesagne.
Data dell’opera: Incerta.
Documento: Video, casetta n°1, e scritto.
Scopo: Orazione del periodo quaresimale.
Note: Della presente preghiera esiste anche la versione scritta dalla stessa intervistata ma in forma italianizzata, però ho preso in considerazione solo quella che mia madre recita nel video.
_______________________________________________________________________________________________
Lu piantu ti Ggesù
Lu piantu ti Ggesù, Maria s’affanna,
Ggesù fu flagellatu alla culonna,
fu ribattutu ti core e di lama.
Giuta ca lu tradiu na ssi lu sonna
lu piantu amaru ci fa la Matonna.
“Vieni, Giovanni, a consolare Maria,
vieni, Giovanni, a quanto amore ti porto,
dimmi se lu mio figlio è vivo o morto?”
“Se vivo o morto noi lo troveremo.
La via ti Caefasso noi faremo.”
Ma quando arrivara a quera gran città,
ti dda sintera na sulenni voci.
“So questi li pieti lavati
ti casa ti Simone e Maddalena.”
Mo passa la lancia e la cavelleria,
li chioti e li martelli priparati.
Mo passa Cristu e dici:
“Madre mia, io vao alla morte
e tu pazienza avia.”
Maria sola sola si partia
squazata e muta e senza cumpagnia.
Ccontra Pietru e Giovanni pi lla via:
“Pietru e Giovanni, Pietru e Giovanni,
c’è lla tu vistu llu tuo caro maestro?”
“Nui l’amu vistu e ci siamo stati,
sopra nnu legnu sta murtificatu,
nui l’amu vistu e amu stati cu issu,
sopra nnu legnu sta pi crucifissu.”
Ma quandu a monti Calvariu lu mintera.
“U quantu sta iertu lu mio caro figlio.”
“Madre mia che si vinuta pi lla via,
solu nnu gnuttu t’aqcua mi daria.”
“Non so vinuta né pi acqua nè pi funtana,
ma so vinuta sola pi lla via,
Ma ci la testa ti putivi ‘ncrinari
iu la minnuzza a mmocca ti daria.”
E iata a ci la tici st’orazioni
lo aiuta Cristu e lu pirdona,
e ci la tici ti vennerdia
lo aiuta Cristu e la mamma Maria,
e ci la tici tre vvoti la notti
l’aiuta Cristu di mala morti.
Aggiungi il tuo testo...


 L'articolo della GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO
L'articolo della GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO
 da sx. MONSIGNOR ANGELO CATAROZZOLO - AVV. STEFANIA ZUFFIANO' - SINDACO FRANCO DAMIANO - DOTT. DINO DEL PRETE - DOTT. ENRICO TURRISI
da sx. MONSIGNOR ANGELO CATAROZZOLO - AVV. STEFANIA ZUFFIANO' - SINDACO FRANCO DAMIANO - DOTT. DINO DEL PRETE - DOTT. ENRICO TURRISI
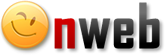
Crea il tuo sito Gratis, Facile e Professionale!
www.onweb.it
